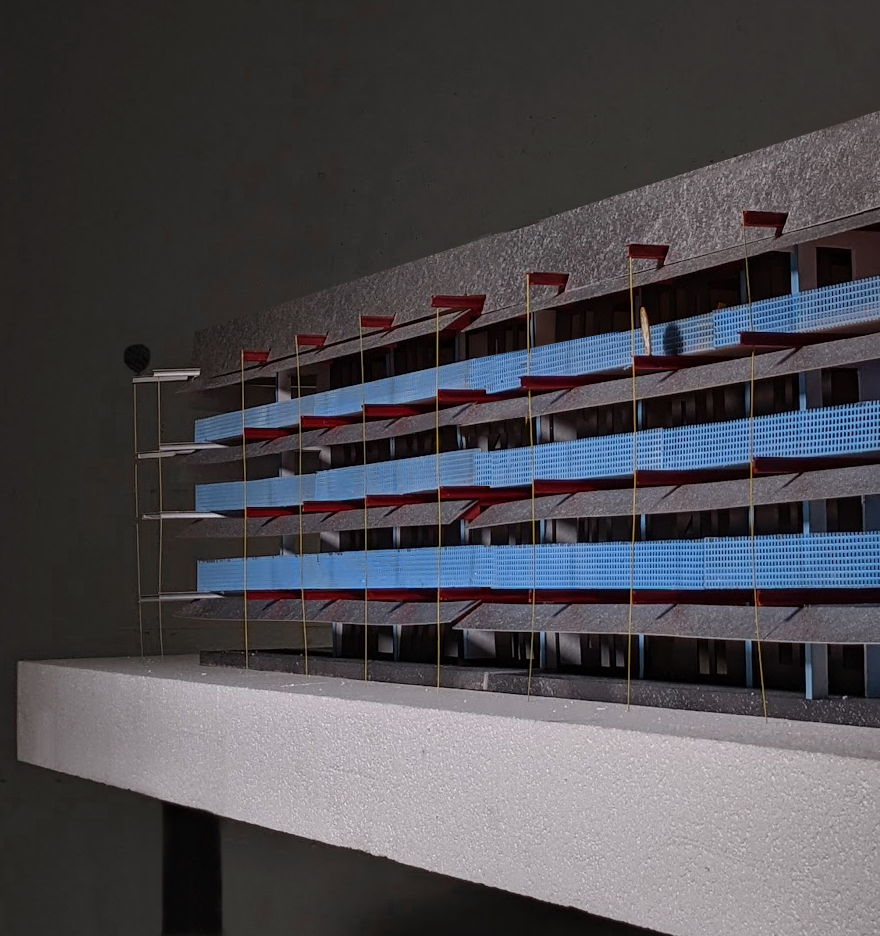Luigiemanuele Amabile in conversation with Thomas Padmanabhan.
In a context of multiple crises like the one we are experiencing, architecture has little room to shape public discourse. The contemporary design process – so complex and shaped by countless variables – makes the coexistence of teaching and professional practice one of the few viable ways to explore alternatives and envision possible futures. Thomas Padmanabhan, who collaborates in education with his partner in practice Oliver Lutjens, seeks to stimulate imagination, empowering students to construct a tangible world through architectural design. This highlights the critical role of bridging architecture schools and professional practice, fostering a collaborative approach that balances intuition and control, imagination and pragmatism – while embracing the diverse contributions the world offers architecture, and how architecture might meaningfully respond.
—
LA: How do you organise your design studio?
TP: No, we felt that the problem with the typical studio design is that you approach a project from the outside – and only very late in the process do you become fully immersed and begin to see the project from within. We wanted to invert that process: to create an “inside view” as early as possible and work from within quickly. We said: let’s put intuition at the beginning. Intuition takes you far. Then, as a second step, you analyse your own intuition. We believe intuition is powerful because it carries an inherent intelligence that helps you synthesize seemingly contradictory aspects of a project – say, the façade and the plan, or urbanism and form. When you do that, you get results. You get plans, you get models. Sometimes, in the second step, you need time to rationalize and understand why you did something – not necessarily to change it.
LA: Would you say that a great deal of intelligence and sensitivity is embedded in that initial intuitive act?
TP: Exactly. And in the second step, you slow down and analyse what you did – and draw it. We often insisted, for example, that students not treat their sketches as just diagrams. We told them, «It’s not a diagram, it’s the design». Sometimes we asked them to scan their sketch and redraw it because it contained far more information than they realized: proportions, relationships between parts, elements, even line weight – everything carried meaning. We kept revisiting that initial sketch many times during the process. It helps students dive into their project quickly and reduces the anxiety that creative people – students, professionals alike – often feel at the start. After three weeks, each student has a project. That’s comforting. Everything after that is just development. So they’re not left wondering, «Do I have something, or do I have nothing?».
LA: Through this approach, you’re also emphasising the importance of process.
TP: Yes, we deeply believe in process – doing many small steps, one at a time. The smaller the step, the clearer your thinking. It’s like in a scientific experiment: if you change just one variable, you can evaluate its impact. But if you change three things at once, you won’t know why the outcome is good or bad.
LA: It looks like you are pushing for artistic intuition at the beginning, but then applying a kind of control – almost scientific – later on?
TP: I wouldn’t even say scientific – more empirical. And also discursive. Because architecture is a public, communal art. When you bring subjective material into the studio, you’re placing it in a sort of small society – the studio – which stands for the larger society. Student peers will ask, «Why did you do this here?» or «Why that there». Suddenly, the project is understood as communal, not just individual. And showing that these two aspects – individual and communal – aren’t contradictory is crucial. We believe you can only do something good for others if it’s also good for you.
LA: At ETH Zurich, there has been an ongoing discussion about the relationship between architectural education and practice. What you’re describing seems to reflect that alignment. Could you elaborate on how you manage that relationship?
TP: For us, it comes naturally. Both in teaching and in practice, it’s a collaborative process. Initially, it was just Oliver Lutjens and me, but now we have a larger team. And for us, the project conversation is the heart of everything. We sit at the table and talk, work physically on the model, on the plan. We literally print plans and draw on them by hand – using white-out, pen, whatever. It’s not abstract sketching; it’s physical, tangible work. And when you work like that – on the artifact of the plan – anyone in the team can contribute. It’s not about the genius line or some individual vision. I can work on one corner, a colleague on another, and it all gets layered together and integrated back into CAD. What we try to teach – something we weren’t taught ourselves – is to take one step at a time. Whatever you know, draw it, build it, visualize it. Then look at it, reflect, and take the next step.
LA: That brings something else to mind. What are the key differences between how you were taught and how you approach teaching today? You’ve studied in several places and worked with major figures – how has that influenced your studio methodology?
TP: That’s a very interesting question. Oliver and I had quite different educations. He would probably speak about the influence of Hans Kollhoff, whose teaching had a huge impact on his understanding of process, seriousness, and precision. I studied in Aachen. At the time, the teaching was structured mostly around the profession, but lacked cultural depth. I felt that right from my first year. I was lucky to study with Jan Pieper, who brought a sense of anthropology to architectural history. His teaching opened up a world of meaning and possibility. But there was also a kind of nihilistic view of the profession in some of the rest of the curriculum. Later, I studied in Rome with Paolo Angeletti. He wasn’t a particularly prominent designer, but he was a deeply thoughtful figure – rooted in history but attuned to the present. Then at Cornell, where I did my master’s, I worked with Arthur Ovaska (Hans Kollhoff’s former partner), Simon Ungers, and Lee Hodgden – one of the last of the Texas Rangers. That environment was imaginatively rich. But I only saw the connection between cultural ambition and built work when I joined Diener & Diener. There, Roger Diener exemplified how serious and sensitive a creative search could be. Even though their buildings look confident and stable, the process was full of doubt and fragility. That was eye-opening for us.
LA: It’s fascinating how these diverse cultural and educational influences have shaped your approach. Would you say your practice operates on the same ethical foundation as your teaching? How do you maintain that alignment?
TP: I wouldn’t say we’re better than others, but we try. In our practice, we address issues like the cost of housing, urbanism, social responsibility. We’re also interested in the societal implications of architectural language. In teaching, we want to empower students. Of course, we also transmit values, but we want them to be confident and articulate. As practitioners, we learn to absorb many external demands. We believe in inclusive architecture – not exclusive. That means not purifying or distancing ourselves from life, but including everything. That inclusivity reflects what kind of society we want to live in. And it helps students become agile – not opportunistic, but flexible. We teach architecture as an affirmative profession, not a critical one. We want students to see every building as a contribution, not a commentary.
LA: Do you intentionally place more emphasis on affirmation and encouragement, even while recognising the necessity of making critical choices?
TP: Exactly. Design still requires tough decisions and hard work. But we think society today – especially in pluralistic democracies – is more open to diversity than our field is. So why shouldn’t architecture reflect that richness? We see it as a good thing.
LA: It seems you think that one of the most important aims of today’s design studio is to cultivate an attitude of engagement and the ability to navigate the complexities of architecture and time.
TP: I’d say we need more joy. The joy of moving through the world openly, working with what you’re given. Sure, in Switzerland we’re often privileged, but freedom as an architect isn’t given – it’s discovered. You find it in the cracks: a law changes, a site opens a possibility, a client makes room for something new. Anselm Stalder, a Swiss artist, speaks about deficit spaces. These are the gaps in a shifting world, spaces that open up, where new things can happen. In architecture, it’s the same. Program, budget, law – none of them are stable anymore. So you have to be curious and alert to find those openings.
LA: You’ve consistently worked as a visiting professor. Was this a conscious decision? How has that influenced your approach to education?
TP: We like teaching together, and permanent positions sometimes don’t allow that. But the experience has been incredibly enriching. Changing schools, cities, and meeting new people forces you to adapt your teaching. Every school has its strengths and weaknesses. For example, at TU Munich, students had a strong foundation in urbanism and the city – but that strength sometimes meant they avoided questioning things. So we had to push them. At Harvard GSD, the students were incredibly fast and talented, but there was no common base to build on. Still, we found the diversity enriching.
LA: Could it be that this visiting model actually supports the kind of teaching you value? Would the freedom and adaptability be harder to maintain in a permanent role?
TP: Exactly. The longer you teach, the more you need to structure and conceptualize your ideas. But with permanence, you also build shared knowledge with students and colleagues. At Harvard, we only taught every second semester, so there was little continuity. Maybe we’d have to theorize more if we were in one place full-time. But even then, we’d still want to keep the strong connection between our practice and our teaching.
LA: I believe that too. Thank you so much.
______________________________________________________________________________________________
Insegnare dall’interno: l’architettura come pratica e processo
Luigiemanuele Amabile in conversazione con Thomas Padmanabhan.
In un contesto di molteplici crisi come quello attuale, l’architettura dispone di spazi sempre più ristretti per riuscire a influenzare il dibattito pubblico. Il processo progettuale, oggi, reso complesso da una crescente quantità di variabili, fa della compresenza tra l’insegnamento del progetto di architettura e pratica professionale una delle poche condizioni attraverso cui esplorare alternative e immaginare futuri possibili. Thomas Padmanabhan, che si occupa di insegnamento insieme al co-fondatore del loro studio Lütjens Padmanabhan, Oliver Lütjens, crede che sollecitare l’immaginazione, mettendo gli studenti in condizione di avvicinarsi alla concretezza dell’architettura attraverso il progetto, si una postura necessari. Essa richiede una relazione ravvicinata tra scuola e professione, capace di sostenere un approccio collaborativo che tenga in equilibrio intuizione e controllo di plurimi aspetti, tra capacità d’immaginazione e pragmatismo, accogliendo la pluralità delle sollecitazioni che il mondo offre all’architettura e interrogando le modalità con cui essa può rispondere in modo significativo.
LA: Come organizzate i vostri laboratori di progettazione?
TP: Nella nostra esperienza, ci siamo resi conto che, nella forma consueta del laboratorio, il progetto viene affrontato dall’esterno e solo in una fase piuttosto avanzata si riesce davvero a entrarci e a vederlo dall’interno. Abbiamo cercato di invertire questa traiettoria, producendo il prima possibile una condizione di visione interna e lavorando a partire da essa. All’inizio poniamo sempre l’intuizione. L’intuizione ha una forza autonoma. L’analisi di quanto prodotto arriva in un secondo momento. Pensiamo che l’intuizione sia espressione di un’intelligenza incarnata che è in grado di tenere insieme aspetti anche contraddittori di un progetto, come, ad esempio, le facciate e la pianta, o l’impianto urbano e la configurazione volumetrica. In questo modo, il progetto prende forma: si tracciano piante, emergono modelli. Talvolta, nella fase di analisi, è necessario prendersi del tempo per capire il perché di una scelta, senza che questo implichi necessariamente la sua correzione.
LA: Diresti che in quell’atto intuitivo iniziale è già contenuta una grande quantità di intelligenza e sensibilità?
TP: Sì, nella fase analitica si rallenta per valutare ciò che è stato fatto ridisegnandolo. Abbiamo insistito molto, per esempio, sul fatto che gli schizzi non sono semplici diagrammi, ma un vero e proprio materiale di progetto. Talvolta abbiamo chiesto loro di scansionare e ricalcare i propri schizzi, perché contenevano molte più informazioni di quante se ne percepissero inizialmente: proporzioni, relazioni tra le parti e presenze formali. È possibile rintracciare un significato persino nella densità del tratto. Abbiamo fatto riferimento a quello schizzo più e più volte nel corso del processo. Questo ha permesso agli studenti di entrare rapidamente nel progetto e di ridurre l’ansia che spesso si prova nella fase iniziale. Dopo tre settimane, ognuno stava già lavorando a uno schema di progetto. Questo passaggio è rassicurante. Tutto ciò che segue è solo soggetto a sviluppo. Non si resta più nell’incertezza: «Ho qualcosa in mano oppure niente?».
LA: Attraverso questo metodo sembra che attribuiate un peso rilevante al processo.
TP: Assolutamente sì, diamo molta importanza al processo, inteso come una serie di piccoli passi. Più il passo è ridotto, più il pensiero risulta chiaro. È simile a ciò che accade in un esperimento: se si modifica una sola variabile, allora è possibile valutarne l’effetto; se se ne modificano tre contemporaneamente, non si riesce più a distinguire da quale di esse provenga il risultato.
LA: Da ciò che descrivete, sembra che in una prima fase incoraggiate l’intuizione, per poi applicare, in una seconda, un certo livello di controllo. È corretto?
TP: Non parlerei di un controllo, quanto piuttosto di un approccio empirico e, allo stesso tempo, discorsivo. L’architettura è un’arte pubblica e condivisa. Quando uno studente porta in aula un materiale soggettivo, lo introduce in una piccola comunità, rappresentata dal laboratorio di progettazione, che a sua volta rappresenta un campione della società su scala più ampia. Gli studenti degli altri corsi si fermano a chiedere: «Perché hai fatto così in questo punto?». In questo modo, il progetto si configura come qualcosa che appartiene alla collettività e non come uno sforzo esclusivamente individuale. È importante mostrare che queste due dimensioni non sono in contraddizione. Siamo convinti che sia possibile fare qualcosa di valido per gli altri solo se è valido anche per chi lo produce.
LA: All’ETH di Zurigo è in corso una discussione continua sul bilanciamento tra formazione e pratica professionale, tra ciò che si insegna e ciò che poi si fa effettivamente. Quello che descrivi sembra invece riflettere la compresenza delle due dimensioni. Come gestite il rapporto tra formazione e pratica professionale? Tra questi due mondi?
TP: Per noi si tratta di un atteggiamento che ci risulta naturale. Sia nell’insegnamento che nella pratica, lavoriamo attraverso un processo collaborativo. All’inizio eravamo solo io e Oliver, mentre ora abbiamo un gruppo più ampio. Il fulcro del nostro lavoro rimane sempre la conversazione sul progetto. Ci sediamo allo stesso tavolo e interveniamo direttamente sul modello e sulla pianta. Stampiamo le piante e le modifichiamo con bianchetto, penne e colori diversi. Non si tratta di uno schizzo astratto, ma di un lavoro concreto che ha delle ricadute reali. In questo modo, chiunque nel gruppo può contribuire. Non esiste il tratto geniale di un singolo individuo. Io posso lavorare su un angolo, un collega su un altro, e poi tutto si stratifica e si reintegra infine nel disegno digitale. Cerchiamo di trasmettere qualcosa che noi stessi non abbiamo ricevuto in forma esplicita: procedere un passo alla volta. Qualunque cosa si conosca, la si disegna, la si costruisce e la si rende visibile. Poi la si osserva, la si discute e si compie il passo successivo.
LA: Quali sono, a vostro avviso, le principali differenze tra la formazione che avete ricevuto e il modo in cui insegnate oggi? Avete studiato in contesti diversi e con docenti molto diversi tra loro. In che modo queste esperienze hanno influenzato il vostro metodo?
TP: In effetti, io e Oliver abbiamo ricevuto formazioni piuttosto diverse. Lui sicuramente farebbe riferimento all’influenza di Hans Kollhoff che ha inciso in modo significativo sulla sua comprensione del processo progettuale insegnandogli l’importanza della serietà e della precisione. Io, invece, ho studiato alla RWTH di Aquisgrana. All’epoca, l’insegnamento era orientato soprattutto alla professione, ma piuttosto povero dal punto di vista culturale. Me ne sono reso conto già dal primo anno. Ho però avuto la possibilità di seguire le lezioni di Jan Pieper, che ha riportato la storia dell’architettura a una prospettiva antropologica e ha aperto alla possibilità di attribuire un senso al progetto. Una parte del programma di studi, invece, sosteneva una visione più nichilista della professione. In seguito, ho studiato a Roma con Paolo Angeletti. Non era una figura particolarmente attiva nel dibattito disciplinare, ma era molto lucido, ben radicato nella storia e attento al presente. Poi, durante il master a Cornell, ho lavorato con Arthur Ovaska (che era stato socio di Kollhoff), con Simon Ungers e con Lee Hodgden, uno degli ultimi dei Texas Rangers. Lì il clima era molto aperto all’immaginazione. Tuttavia, ho compreso il legame tra ambizione culturale e costruzione solo quando sono entrato a far parte dello studio Diener&Diener. Roger Diener mi ha insegnato che la ricerca progettuale può essere rigorosa e sensibile allo stesso tempo. Anche se gli edifici apparivano molto equilibrati negli esiti, il processo progettuale era costellato di dubbi. Questo passaggio è stato decisivo per me.
LA: È interessante notare come queste influenze, complementari tra loro, abbiano contribuito a definire il vostro modo di lavorare. Si può affermare che lo studio e la didattica si basino sullo stesso impianto etico? In che modo riuscite a mantenere questa coerenza di intenti?
TP: Non direi che siamo migliori di altri, ma cerchiamo di assumerci le nostre responsabilità. Nella pratica, ci confrontiamo con questioni quali il costo dell’abitare, gli aspetti urbani e le caratteristiche sociali dell’architettura. Ci interessano anche le implicazioni linguistiche, ovvero il modo in cui le forme architettoniche contribuiscono alla costruzione del senso comune. Nella didattica, invece, cerchiamo di mettere gli studenti nelle condizioni di agire e di acquisire fiducia nel proprio lavoro. È evidente che proviamo a trasmettere dei valori, ma l’obiettivo è che questi possano essere elaborati in modo autonomo. Nella professione si impara ad assorbire molte sollecitazioni esterne e questo richiede elasticità. Cerchiamo un’architettura inclusiva, non esclusiva. Non ci interessa purificare o separare l’architettura dalla vita, ma lavorare con ciò che esiste. Questa impostazione, che accoglie la complessità, riguarda anche il tipo di società in cui desideriamo vivere. Siamo convinti che l’insegnamento debba sostenere queste prospettive, rendendo gli studenti più capaci di riconoscere gli spazi di possibilità, ma anche di non essere opportunisti. Insegniamo l’architettura come pratica affermativa, non come critica del mondo. Crediamo che ogni edificio sia un contributo, non un commento.
LA: Quindi, ponete intenzionalmente maggiore enfasi sull’affermazione e sull’incoraggiamento degli studenti, pur riconoscendo la necessità di compiere scelte critiche.
TP: Esattamente. Il progetto richiede comunque decisioni difficili e un lavoro rigoroso. Tuttavia, riteniamo che la società contemporanea, soprattutto nelle democrazie pluraliste, sia più aperta alla diversità rispetto al nostro ambito disciplinare. Perché l’architettura non dovrebbe riflettere questa ricchezza? Per noi è un valore.
LA: Dalle tue parole emerge la volontà di individuare, tra gli obiettivi principali dei vostri laboratori di progettazione, l’invito ad affrontare con coinvolgimento e accogliere con entusiasmo la complessità dell’architettura e del nostro tempo.
TP: Direi che abbiamo bisogno di più gioia. La gioia di affrontare il mondo con uno sguardo ampio e di lavorare con ciò che ci viene fornito. È vero, in Svizzera partiamo spesso da condizioni privilegiate, ma la libertà per un architetto non è qualcosa di scontato: va scoperta. La si trova negli interstizi, negli scarti, nei punti di flessione in cui una normativa cambia, in un sito che offre possibilità inedite o quando un committente lascia spazio a deviazioni non convenzionali. L’artista svizzero Anselm Stalder parla di spazi di deficit: varchi che si aprono in un mondo in movimento, in cui possono accadere cose nuove. In architettura accade lo stesso. Programmi, budget e normative: nulla è stabile in modo definitivo. Per riconoscerli, servono curiosità e attenzione.
LA: Avete spesso lavorato come professori a contratto in diverse scuole. È stata una scelta? In che modo questa condizione ha influenzato il vostro approccio alla didattica?
TP: Insegnare insieme ci appassiona, e le posizioni permanenti non sempre lo consentono. Queste esperienze sono state comunque molto formative. Cambiare scuola, città e contesti e incontrare persone diverse ci ha costretti ad adattare continuamente il nostro modo di insegnare. Ogni scuola ha i suoi punti di forza e i suoi limiti. Alla TU Munich, per esempio, gli studenti avevano una solida base sui temi della città e sull’urbanistica, ma proprio questa loro forza talvolta li portava a non mettere in discussione ciò che avevano già acquisito. Abbiamo dovuto spingerli oltre i loro limiti. Gli studenti di Harvard GSD, invece, erano molto rapidi e talentuosi, ma mancava una base comune da cui partire. Tuttavia, questa eterogeneità si è rivelata molto utile.
LA: Si può affermare che questo modello itinerante sostenga il vostro modello di insegnamento? Sarebbe più difficile mantenere questa libertà in un solo luogo?
TP: Probabilmente sì. Più a lungo si insegna nello stesso luogo, più si sente la necessità di strutturare e concettualizzare ciò che si fa. Allo stesso tempo, però, una posizione permanente permette di costruire un sapere condiviso con gli studenti e i colleghi. Ad Harvard, invece, insegnavamo solo a semestri alterni, quindi la continuità era limitata. Forse, se restassimo nello stesso posto a tempo pieno, potremmo dedicare più tempo agli aspetti teorici. In ogni caso, vorremmo mantenere un legame forte tra la pratica professionale e l’insegnamento.
______________________________________________________________________________________________
Luigiemanuele Amabile – Architect and PhD, research fellow of the project DT2 (UdR Università degli Studi di Napoli “Federico II”).
Thomas Padmanabhan – Architect at Lütjens Padmanabhan Architekt*innen.